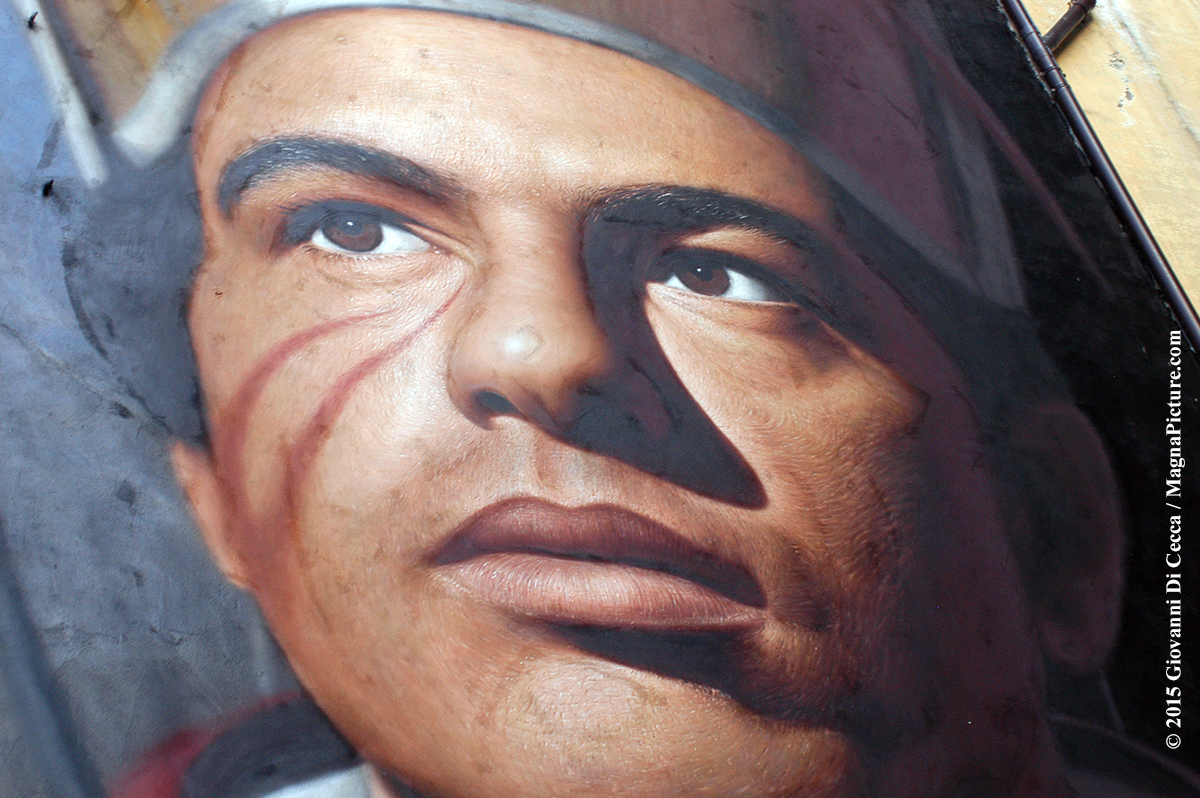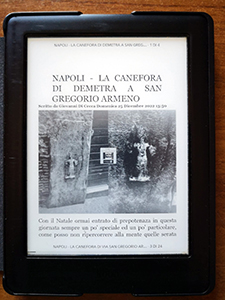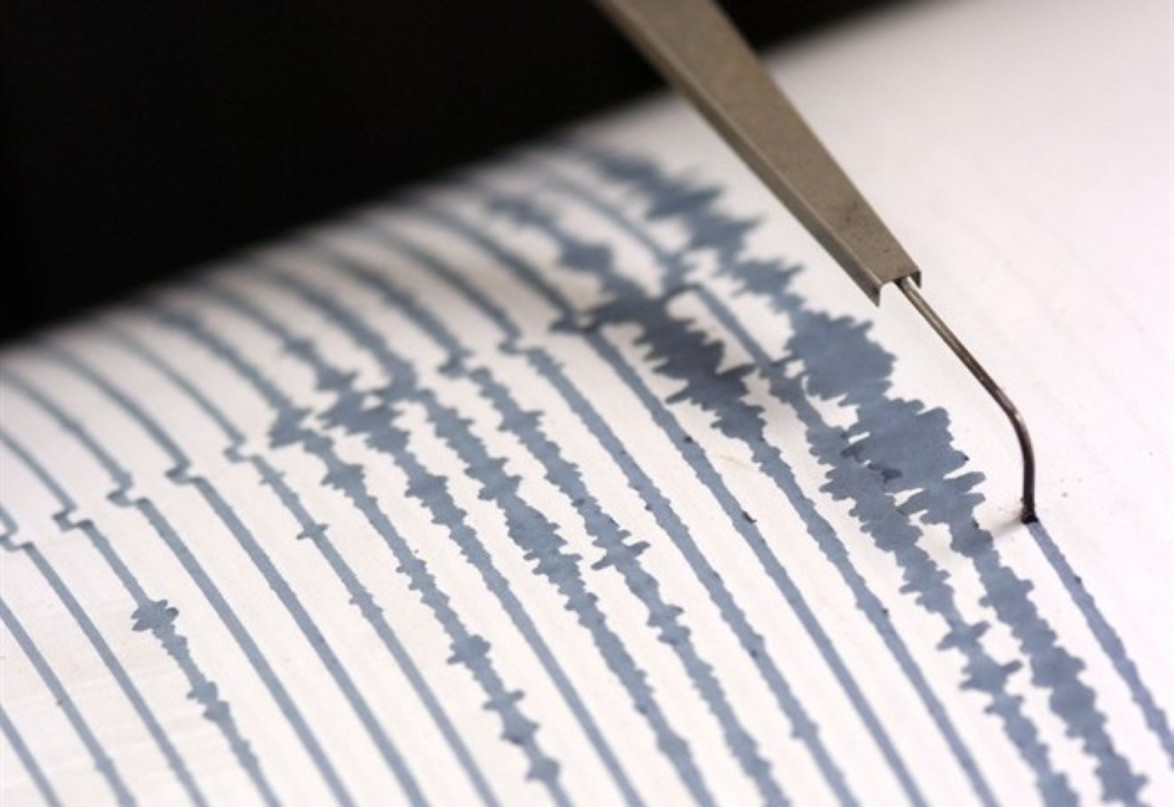| Napoli - La Canefora di Demetra a San Gregorio Armeno |
 |
| Scritto da Giovanni Di Cecca | |||||||||||
| Domenica 25 Dicembre 2022 14:50 | |||||||||||
|
>>> Da questo articolo, l'eBook Gratuito su Kobo (clicca qui)
Con il Natale ormai entrato di prepotenaza in questa giornata sempre un po' speciale ed un po' particolare, come posso non ripercorrere alla mente quelle serata di, ormai tanti anni fa, quando avevo qualche anno in meno e qualche capello in più, in quelle che chiamavamo i Sabati di Avvento (in contrapposizione alle domeniche che erano quelle successive) in cui tra un panzarotto e una pasta cresciuta, in quel momento molto particolare che furono gli anni '90 del XX Secolo, a casa mia si parlava di storia di Napoli e delle sue tradizioni.
A tener banco non poteva essere che il mio caro Zietto, purtroppo nella schiera dei più che ci hanno lasciato, che prima di essere medico era soprattutto un napoletano di quelli che i libri su Napoli se li era letti tutti, e in quelle serate di Natale (dove faceva veramente freddo, orami potremmo dire prima del climate change) teneva banco con la sua proverbiale dialettica e ci raccontava le storie del presepe, il simbolismo dei pastori di cui Napoli e non più Gerusalemme ne erano lo sfondo
Naturalmente in quelle serate spesso aleggiava anche la figura di un altro grande esperto di arte presepiale come Gennarro Borrelli (che ci ha lasciato nel 2019 alla veneranda età dei 98 anni), di cui Zio era un grande amico e con il quale spesso si confrontava e ci raccontava a mo' di cenacolo, idee scoperte ecc.
In quelle serate, in cui io stedente tra le medie ed il liceo a Napoli, nel mio caro "centro antico", come una spugna secca butta in acqua apprendevo storie di quello che si celava sotto i miei piedi.
Non era ancora il tempo delle Napoli sotterranee, degli Scavi visitabili di San Lorenzo, dell'Agorà di Piazza San Gaetano e ben lungi da quella magnifica avventura che fu trovare le carte originali che riuscirono a datare giorno, mese e anno la cosiddetta "Sindone dei Teatini" da cui scaturì la prima (e credo ancora unica) monografia su una singola copia della Sindone al mondo, che scrissi nel 2011.
Napoli, con molta fatica, stava uscendo da quel periodo oscuro e devastante che furono gli anni '70 e '80 del XX Secolo, in cui la malavita sembrava avesse preso il sopravvento e che non ci fosse un futuro per la Città e per noi figli di Parthenope.
Eppure, per quanto assurdo sembri, la mano de D10S, dal cui triplo Big Bang calcistico dei due scudetti e della Coppa UEFA tra la seconda metà degli anni '80 e quel fatidico 1990, anno dello scudetto e di quella maledetta partita al San Paolo (oggi Stadio Maradona) del 3 luglio 1990 tra Italia e Argentina, la Città rinacque dalle sue ceneri per ridiventare protagonista e Capitale come lo fu, diverse volte, nel suo medio ed antico passato.
Ma che c'entra con la Canefora di Demetra a San Gregorio?
I fatti di cui tratterà risalgono a quel tempo ed a come la valorizzazione dei reperti, all'epoca non era così predominante come, per fortuna, lo è oggi.
Chi era Demetra ed il suo mito
Secondo Esiodo, Demetra era la secondogenita di Crono e Rea, e come i suoi fratelli fu ingoiata da Crono appena nata, e salvata in seguito da Zeus.
Da Zeus divenne madre di Persefone ed ebbe Pluto da Iasione.
Secondo Igino da Iasione, ebbe anche Filomelo (definito come gemello di Pluto).
Da Poseidone ebbe il cavallo Arione trasformandosi in Furia o in giumenta. Pausania aggiunge una figlia (Despina)
Infine da Carmanore ebbe Crisotemi ed Eubolo.
Il più importante mito legato a Demetra, che costituisce anche il cuore dei riti dei Misteri Eleusini, è la sua relazione con Persefone, sua figlia nonché incarnazione della dea stessa da giovane. Nel pantheon classico greco, Persefone ricoprì il ruolo di moglie di Ade, il dio degli inferi. Diventò la dea del mondo sotterraneo quando, mentre stava giocando sulle sponde del Lago di Pergusa, in Sicilia, con alcune ninfe (secondo un'altra versione con Leucippe) che poi Demetra punì per non essersi opposte a ciò che accadeva trasformandole in sirene, Ade la rapì dalla terra e la portò con sé nel suo regno. La vita sulla terra si fermò e la disperata dea della terra Demetra cominciò ad andare in cerca della figlia perduta, riposandosi soltanto quando si sedette brevemente sulla pietra Agelasta. Secondo il mito, durante la sua ricerca Demetra ha viaggiato per lunghe distanze e ha avuto molte piccole avventure lungo la strada. In uno dei luoghi insegnò i segreti dell'agricoltura a Trittolemo.
Alla fine Zeus, pressato dalle grida degli affamati e dalle altre divinità che avevano anche ascoltato la loro angoscia, costrinse Ade a riportare Persefone. Tuttavia, era una regola del Fato che chiunque avesse consumato cibo o bevande negli Inferi fosse condannato a trascorrere lì l'eternità. Prima che Persefone venisse rilasciata a Hermes, che era stato mandato a recuperarla, Ade l'aveva ingannata invitandola a mangiare dei semi di melagrana (sei o quattro secondo il racconto) che la costrinsero a tornare negli inferi per alcuni mesi all'anno. Così fu costretta a rimanere nell'Ade per sei o quattro mesi (un mese per seme) vivendo sulla terra con sua madre per il resto dell'anno.
Da quando Demetra e Persefone furono di nuovo insieme, la terra rifiorì e le piante crebbero rigogliose ma per sei mesi all'anno, quando Persefone è costretta a tornare nel mondo delle ombre, la terra ridiventa spoglia e infeconda. Questi sei mesi sono chiaramente quelli invernali, durante i quali in Grecia la maggior parte della vegetazione ingiallisce e muore.
Vi sono comunque altre versioni della leggenda. Secondo una di queste è Ecate a salvare Persefone. Una delle più diffuse dice che Persefone non fu indotta a mangiare i sei semi con l'inganno, ma lo fece volontariamente perché si era affezionata ad Ade.
Non mi soffermerò sui sulla presenza di Demetra a Eleudi e sui Misteri Eleusini (facilmente trovabili in rete), il "più famoso dei riti religiosi segreti dell'antica Grecia", in quanto trascende troppo il nostro discorso, sulla canefora di Via San Gregorio Armeno.
Cos'è una Canefora
canefora f sing (pl.: canefore)
(storia) vergine dell'antica Atene reggente, nelle processioni, una cesta appoggiata sulla testa in cui vi erano riposti alcuni oggetti sacri
(architettura) elemento architettonico che sostituisce le colonne raffigurante una fanciulla che porta un cesto sulla testa
Cenni sulla nascita di Napoli
Se si parla di Natale alla mente vengono sicuramente almeno tre cose: Babbo Natale (di cui abbiamo trattato anni fa nell'ormai classico La Tradizione del Natale tra leggenda e storia), Last Christmas dei Wham, ormai classico inno di Natale dei giorni nostri (di cui abbiamo anche trattato chi fosse "la fidanzata oggetto della canzone"), ed i presepi, in particolare i Pastori, di Via San Gregorio Armeno, al Centro Antico a Napoli.
Come abbiamo riproposto pochissimi giorni fa, Napoli, come Roma, ha una sua data di fondazione (di cui non comprendo ancora perché il Comune non voglia adottarlo come festa locale) che è il 21 dicembre 472 a.C. data del Solstizio di inverno, e com'è noto, i Cumani discesero verso la costa e si insediarono nell’area compresa tra l’isolotto di Megaride (dove oggi sorge il Castel dell’Ovo) ed il Monte Echia (l’odierna collina di Pizzofalcone).
Questo primo insediamento fu chiamato Parthenope, dal nome della mitica sirena che si lasciò morire sull'isolotto di Megaride (come detto, l'odierno Castel dell'Ovo), non tanto per l'amore non ricambiato da parte di Ulisse, ma, sembra, per la dignità persa per non essere stata capace di far innamorare Ulisse, che la ingannò facendosi incatenare all'albero maestro. Questo insediamento divenne una prosperosa e popolosa città.
Nel 524 a.C. gli Etruschi invasero Cuma, senza, tuttavia, riuscirla ad espugnare, allorché gli Etruschi dirottarono verso Parthenope, e Cuma, tutto sommato invidiosa della prosperità della città sul mare, la lascio al suo destino, preferendo vederla distrutta.
Tempo dopo i Cumani alleati con il tiranno di Siracusa Sereone ripresero Parthenope sconfiggendo gli Etruschi. Era il 474 a. C.
Poco dopo i Cumani fondarono una nuova città poco distante dalla vecchia Parthenope, chiamata appunto Nea Polis (città nuova) per distinguerla dalla Pale Polis (città vecchia) che era Parthenope.
Nea Polis da cui nasce Napoli, divenne il centro sociale e culturale, che acquisì sempre più centralità divenendo anche polo privilegiato nei rapporti con Atene, anche rispetto alle altre colonie della Magna Grecia.
Urbanisticamente, la città nuova si sviluppò con un centro, l'Agorà, appunto che era il nucleo principale della società e dove vi erano i templi dedicate alle divinità e dove si amministrava la giustizia e lo Stato.
Quell'Agorà è identificata, oggi, da Piazza San Gaetano.
I Decumani ed il Tempio di Demetra/Cerere a Via San Gregorio Armeno Una volta che la polis divenne, l'attuale centro antico di Napoli, nell'Agorà furono eretti templi alle divinità dell'epoca greca e successivamente romana. Già la stessa Basilica di San Paolo Maggiore, ad esempio, fu eretta come Tempio dei Dioscuri, Castore e Polluce. Castore era domatore di cavalli mentre Polluce si distingueva ottimamente nel pugilato. Erano anche considerati come protettori dei naviganti durante le tempeste marine e furono associati alla costellazione dei Gemelli e alla comparsa della stella Sirio nel cielo in prossimità dell'equinozio di primavera, poiché propiziava la semina dei campi e l'inizio della primavera stessa. Nell'astronomia moderna Castore dà il nome ad Alpha Geminorum e Polluce a Beta Geminorum. Vengono talvolta considerati anche patroni dell'arte poetica, della danza e della musica. Tra l'altro, come a volte accade, una incisione latina posta sopra l'ingresso, porta la seguente dicitura: "Tiberio Giulio Tarso (fece costruire) in onore dei Dioscuri e della Pòlis il tempio e tutto quanto è in esso/Pelagon liberto e procuratore dell'imperatore, avendolo finito a sue spese, lo dedicò". Dal Tempio dei Dioscuri (San Paolo Maggiore) si scende per una una strada, che è doventato, ormai, l'emblema stesso del Natale in tutto il mondo: Via San Gregorio Armeno. La strada risulta essere uno degli stenopori (dal gr.: stenosi, restringimento, e poros, passaggio) tipici dell'architettura urbanistica greca la quale caratterizza tutto il centro antico di Napoli, di cui l'attuale parte visibile, com'è facilmente osservabile dagli scavi di San Lorenzo Maggiore (la basilica posta proprio sopra la strada) oggi visitabili al pubblico In quanto stenoporos (cardine nell'urbanistica romana), la via fungeva da collegamento tra le due plateiai (dal gr.: plateia, piazza) la plateia maggiore (attuale via dei Tribunali) e quella inferiore (odierna Spaccanapoli), ovvero, con nomenclatura romana (e più "moderna") i due Decumani, il Major (Via Tribunali) e l'Inferior (Via Benedetto Croce, Spaccanapoli), le due principali strade dell'antica Neapolis erano dunque congiunte (sia in epoca greca che romana) perpendicolarmente proprio da questa strada, all'altezza della Basilica di San Paolo Maggiore, dove sorgeva, come detto, l'Agorà. Scendendo, quella che oggi è nota come Via San Gregorio Armeno, sulla destra vediamo subito a destra il malconcio edificio settecentesco del Banco del Popolo, un tempo proprietà della Casa degli Incurabili, che possedeva anche un ulteriore palazzo attiguo di un secolo più antico, oggi, in grave stato di abbandono. Più appresso c'è il complesso di San Gregorio Armeno, fondato attorno al 930 d.C. sulle fondamenta dell'antico Tempio di Cerere e che solo nel 1205 la chiesa viene intitolata al santo omonimo. Va detto che il Tempio di Cerere (Demetra) si trovava sotto il complesso di San Gregorio Armeno e questo ce lo narra un grande studioso del XIX Secolo come Bartolomeo Capasso, che sugli studi della Napoli Greco-Romana ne trasse un fondamentale ancora oggi validissimo sostegno a coloro che approcciano alla materia. La Canefora e la tradizione dei Pastori di Via San Gregorio Armeno Per quanto lunghi i passi precedenti, sono serviti per introdurre le due peculiarità di questa strada, intrensicamente connesse con la Napoli che oggi conosciamo La canefora è anche un ex voto e raffigura una donna con un vestito leggerissimo e con un copricapo a forma di corona. In una mano regge una fiaccola e nell'altra un canestro. Come mi ha raccontato (video) un pastoraro di San Gregorio, la scultura non è solo fine a se stessa, ma come le attuali edicole votive era della Città e tutti potevano toccarla, un po' come facciamo oggi con le statue dei "nuovi santi della religione attuale", e quindi non poteva essere coperta
Video - Napoli - Un pastoraro di Via San Gregorio Armeno, racconta la storia della Canefora (2020) Ma non solo. Il fatto stesso che vi era il Tempio di Cerere (Demetra in greco) portava ad un'altra caratteristica, che ancora oggi ci tramandiamo, ovvero le botteghe degli artigiani che fabbricavano delle statue votive della Dea che venivano offerte come ex voto. In buona sostanza da ben prima che il Cristianesimo divenisse la religione dominante, a Napoli (Neapolis), all'attuale Via San Gregorio Armeno, esistevano già le botteghe che producevano "pastori", che ne fa di conseguenza, una delle tradizioni più antiche del mondo (se no la più antica) identitarie non solo di una popolazione, ma per di più di una ristrettissima area geografica come una strada da circa 3.000 anni Non deve fare quindi scalpore se ancora oggi, oltre alla tradizione cristiana del presepe, nelle botteghe di Via San Gregorio Armeno troviamo anche le raffigurazioni di attori, politici, e soprattutto del D10S umano Diego Armando Maradona.
Dedicato alla memoria del dott. Alberto Brancati
Photogallery - Napoli - La Canfora di Demetra a San Gregorio Armeno - 25-12-2022 Photo by Giovanni Di Cecca / MagnaPicture.com --- Archivio Storico dicecca.net - MONITORE NAPOLETANO
|





![header=[canefora1992] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-1992.jpg)
![header=[canefora19922] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-1992-2.jpg)
![header=[canefora1992doppio] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-1992-doppio.jpg)
![header=[canefora20203] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-2020-3.jpg)
![header=[canefora20204] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-2020-4.jpg)
![header=[canefora20205] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-2020-5.jpg)
![header=[canefora20226] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-2022-6.jpg)
![header=[canefora20227] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-2022-7.jpg)
![header=[canefora20228] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-2022-8.jpg)
![header=[canefora20229] body=[]](https://www.monitorenapoletano.it/sito/images/morfeoshow/napoli___la_-8385/thumbs/canefora-2022-9.jpg)